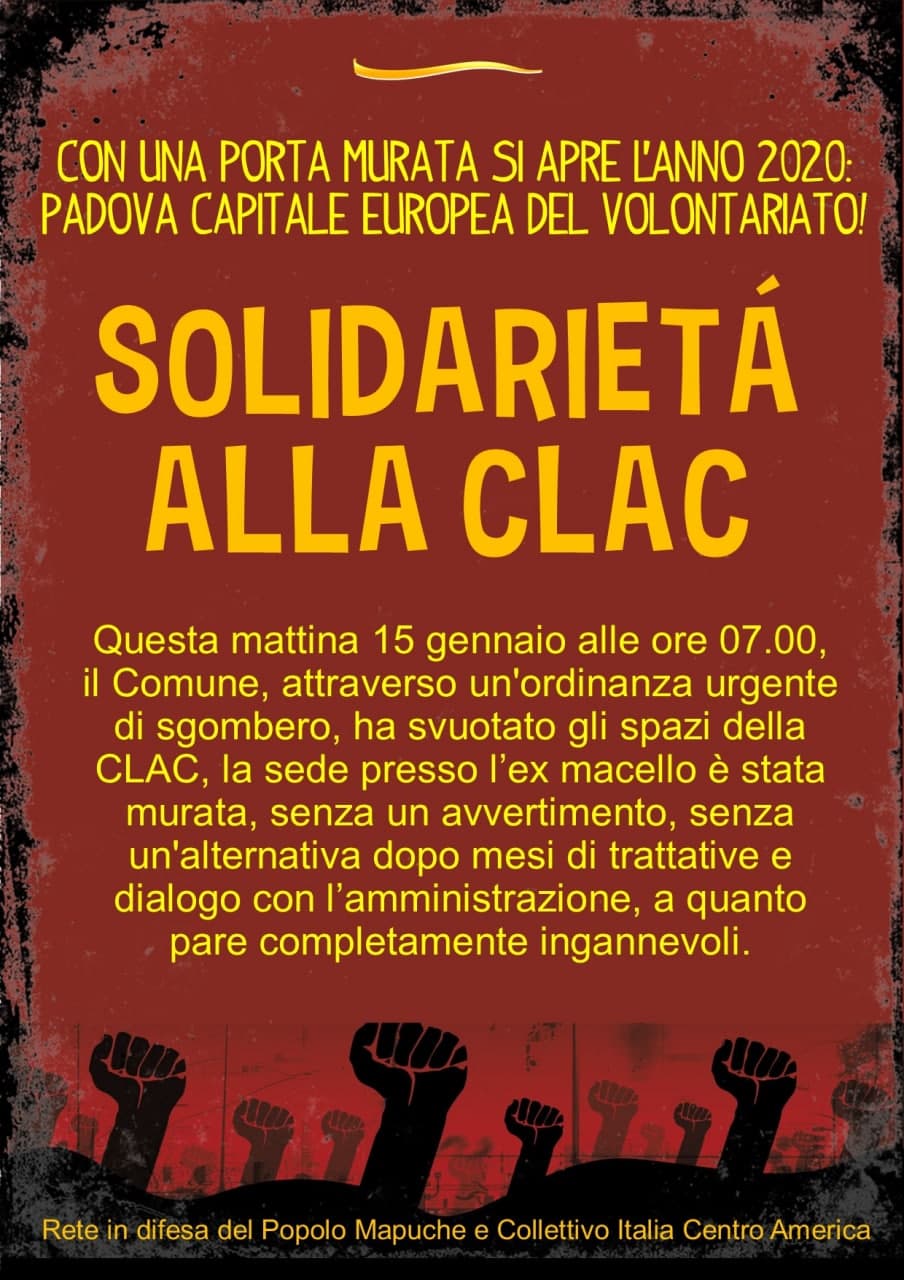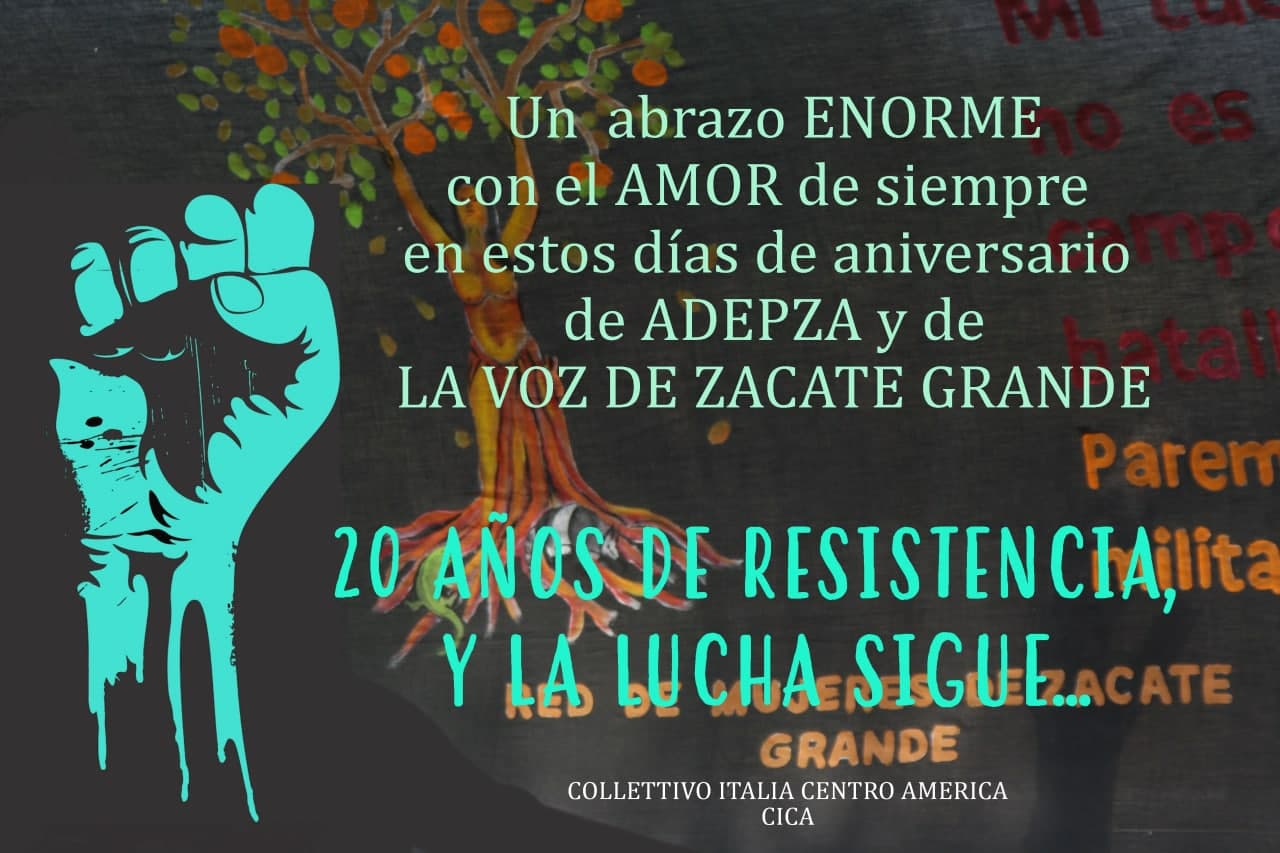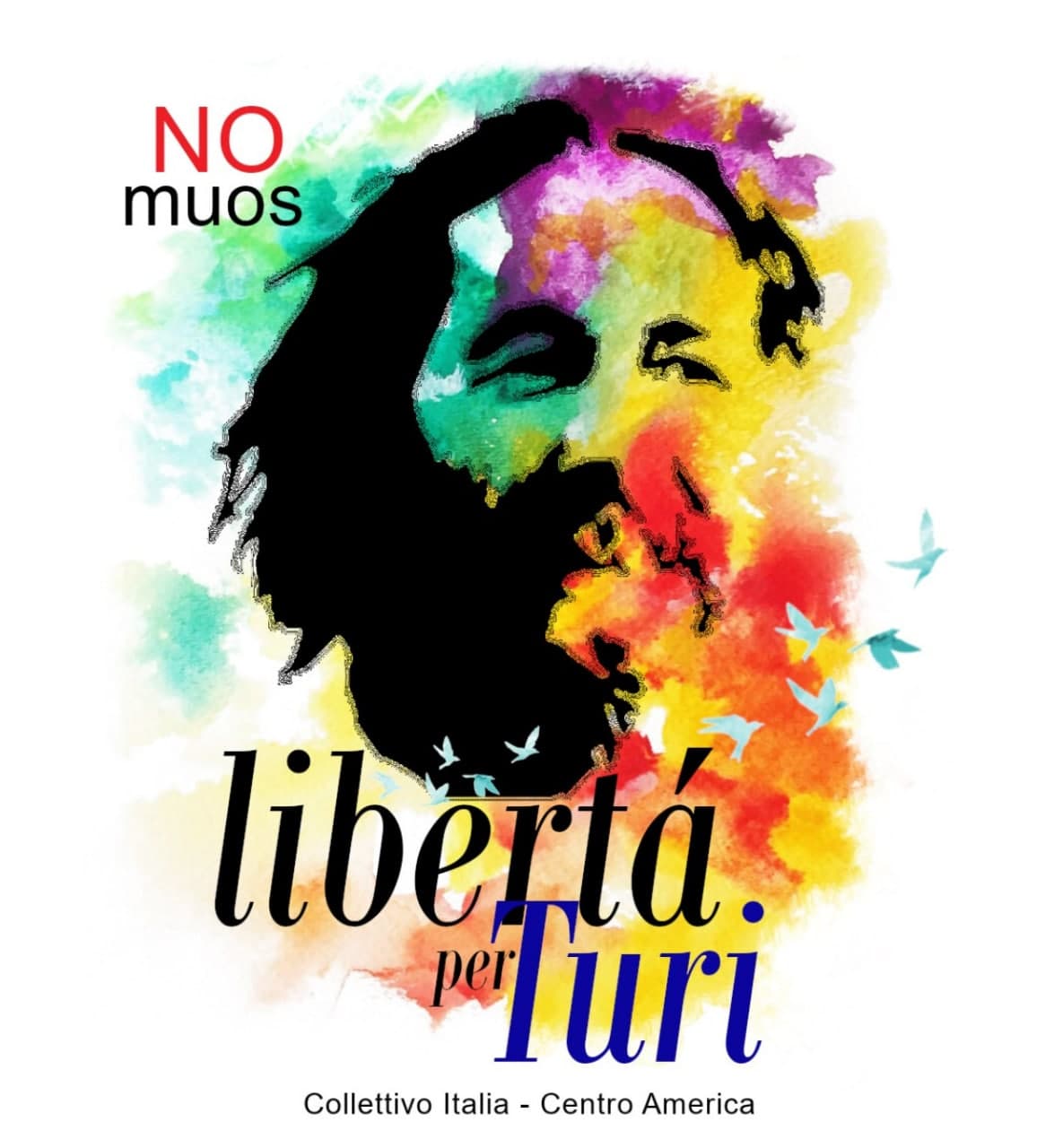di Luca Martinelli
La retorica del “Paese fallito” e di uno “Stato debole” serve solo a giustificare violenza e violazioni dei diritti umani, che non sono frutto dello strapotere dei narcos ma di una precisa organizzazione del potere. I giornalisti italiani lo capiranno mai?

Negli ultimi cinquant’anni la ricchezza prodotta in Messico, misurata dalla Banca Mondiale, si è moltiplicata per quasi quaranta volte (in Italia di 23), e la popolazione del Paese è praticamente triplicata (fino a 127 milioni di persone). Eppure per i media italiani, ancora indecisi sull’appartenenza geografica al Nord o al Centro America, la quindicesima economia mondiale, che è anche il decimo Paese per numero abitanti, è soltanto un cliché, è il “Narcostato”, è il Paese dove oltre 230mila persone sono morte nell’ambito di una presunta guerra alla droga promossa a partire dal 2006 dall’allora presidente Felipe Calderon.
È fatta, e per il lettore italiano l’equazione è pronta, Messico = droga; non era del resto già così ai tempi di Diego Abatantuono e Claudio Bisio protagonisti di Puerto Escondido (1992), tratto dal libro di Pino Cacucci?
Eppure, a dare la colpa di tutto al narcos, cioè a quelli che vengono presentati come cartelli della droga, ha un unico effetto: riduce a zero la complessità del Messico, la complessità che la realtà di ogni Paese vive e contiene (gli italiani non sono stanchi di essere descritti come il Paese dei fannulloni, in mano alla mafia?). Fa sì, questo atteggiamento complice, che non ci si pongano domande (ad esempio, che cosa ha reso possibile una crescita economica così significativa? Chi l’ha pagata? Le relazioni commerciali privilegiate con Stati Uniti, Canada ed Unione europea hanno avuto solo effetti “benefici” sull’economia?), e fa sì che la forza apparentemenre schiacciante dei narcotrafficanti non lasci emergere l’esistenza di uno Stato forte, fortissimo, in particolare quando si tratta di mettere in piedi meccanismi di repressione nei confronti del conflitto sociale. Non fa notizia, in Italia, che un Parlamento in scadenza abbia approvato a dicembre una legge che, in nome della sicurezza pubblica, “apre” alle forze militari le strade del Paese, dove l’esercito sarà impegnato anche negli interventi di ordine pubblico. Una legge condannata anche dalle Nazioni Unite.
Resta il cliché, che in quest’anno elettorale (si vota il prossimo 1° luglio) rischia di essere strumentalizzato ed ingigantito: a dicembre, ad esempio, un lungo articolo pubblicato da un quotidiano ha dato risalto alla storia dei 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa, in Guerrero, scomparsi il 26 settembre del 2014. Bene, ma quello scritto riportava finte o false verità, già smentite scientificamente da anni, come la favola dei corpi che sarebbero stati bruciati in una discarica dopo esser stati affidati ai “narcos”.
Lo stimolo a scrivere questo commento, però, è una frase, letta il 7 gennaio su un autorevole settimanale: “C’è poi la piaga della corruzione, figlia endemica del narcotraffico”.
Non è possibile affermare che in Messico la corruzione è figlia del narcotraffico, e basterebbe guardare agli archivi dell’OCSE, alle classifiche di Transaprency International o anche alle cronache economiche del Paese negli anni Settanta, Ottanta e Novanta (si può leggere ad esempio il coccodrillo dedicato dal Guardian all’ex presidente Lopéz Portillo, in carica dal 1976 al 1982).
Non c’è solo il narcotraffico, il Messico e i messicani non vivono ogni giorno pensando e rivivendo la cattura di “el Chapo”.
Ecco che, sconfitto il fantasma dei narcos, potremmo iniziarci a porre altre domande.
Perché dall’altra parte dell’Atlantico, e legato all’Italia da salde e solide relazioni commerciali (sono stati in visita a Città del Messico: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, luglio 2016; il presidente del Consiglio Matteo Renzi, aprile 2016; il ministro degli Esteri, poi presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, marzo 2015) e da un volo aereo diretto Roma e Ciudad de México, c’è un Paese che negli ultimi quindici anni ha compiuto solidi passi indietro sul terreno della tutela dei diritti umani, in particolare dei popoli indigeni (certificati a novembre 2017 dall’ultima missione della Relatrice speciale ONU), che è sotto processo alla Corte interamericana per i diritti umani per tortura, anche sessuale, nei confronti di cittadini che manifestavano la propria contrarietà ad una grande opera (il “caso Atenco”, così simile alla nostra Genova), che ha privatizzato le riserve di petrolio e gas, che sui migranti si è trasformato in un argine per conto degli Stati Uniti d’America.
Nel 2014, a Tenosique, in Tabasco, nei pressi della frontiera con il Guatemala, ho capito che Messico ed Italia sono simili, due Paesi di transito per migliaia di migranti che non vogliono restare entro quei confini. A partire dalla metà degli anni Novanta (e personalmente nei primi anni Duemila), invece, l’Esercito zapatista di liberazione nazionale in Chiapas ha insegnato a migliaia di persone in tutto il mondo l’importanza di lottare contro le politiche neoliberiste. Ecco perché il Messico non può essere considerato una “sconfinata ecatombe” (letto sempre domenica 7 gennaio, sull’inserto culturale di un quotidiano), ma resta un Paese da indagare nella sua gigantesca complessità. Quella che nel 2018 porta per la prima volta una donna, che è anche un’indigena, a tentare la candidatura alla presidenza della Repubblica. Il segnale, anche se il nome di Marichuy, all’anagrafe Maria de Jesus Patricio Martinez, non dovesse arrivare sulla scheda elettorale, di un Paese ancora vivo. Oltre ogni cliché.
fonte: https://medium.com/@lucamartinelli130180/una-dolorosa-lettera-damore-per-il-mio-messico-c092e6c3a4ad